Ad un certo punto però Trevisan si sente saturo, quel palcoscenico che si era costruito nelle prime opere – e anche qui il parallelismo con Palladio può apparire adeguato se pensiamo ad almeno due opere quali il teatro Olimpico e la Rotonda, veri palcoscenici – attraverso la maschera dei suoi personaggi, come ha ben descritto Emanuele Trevi(6), questa viene gettata.
Ora è l’uomo Vitaliano in prima persona a mettersi in gioco e quando ormai, credo profondamente deluso da questo mondo, decide che altri mondi sono da esplorare, perché molto più ricchi di contaminazioni; per inciso, quelle stesse contaminazioni le aveva sempre cercate anche come musicista.
In Black Tulips cambia tutto, e con la forza di un reporter d’eccezione cambia la sintassi e ricerca una nuova relazione tra il frammento e la continuità del testo pur nella contingenza di narrare storie vere: il movimento dei popoli prima di tutto, un senso di “compassione” verso gli ultimi – si cfr. la storia di Hellen in Black Tulips – la costrizione e la sopraffazione di interi popoli, la tratta dei neri, la prostituzione, la nostra storia occidentale che va in frantumi, la ricerca ossessiva di questa contemporaneità che mira al successo, i soldi, l’apparire fine a stesso senza contenuti da offrire.
Ho già avuto modo di affermare un fatto noto, e pertanto privo di originalità, ma Trevisan è forse l’unico scrittore italiano dell’ultimo mezzo secolo trascorso, insieme a Pasolini, che non fa il melenso, che non brandisce l’accoglienza come un senso di alta civiltà, che parla dal suo divano.
Lui migra, va a vedere, butta il suo corpo nella mischia. Lascia questo mondo pieno di ipocrisia e va, in piena solitudine, senza codazzi di telecamere o testate giornalistiche di supporto. Del resto il suo amato nord-est non l’ha mai amato, ma lui non ricerca consenso, gli è indifferente, gli basta vedere, osservare e scrivere perché la scrittura come dice Thomas in Un mondo meraviglioso, è come l’aria.
Senza di essa non puoi vivere.
In questa idea di movimento ho trovato una bella affinità con una recente dichiarazione Koyo Kouoh, prima curatrice africana della Biennale Arte di Venezia. Mi sono chiesto cosa avrebbe pensato Vitaliano di queste sue parole, peraltro subito commentate in maniera malevola da una certa cultura che fatica ad accettare i cambiamenti e le contaminazioni: «l’arte è movimento, vivere è migrare».
Mi pare questo un buon manifesto per progettare il futuro al quale Vitaliano, credo, avrebbe aderito.
Mi torna alla mente una sua mail, a seguito di un incontro fortuito nel quale ci soffermammo a lungo a parlare del nostro paese, nella quale si dichiarava diversamente impegnato politicamente, rimarcando che le sue scelte erano una decisa scelta politica, ciò a significare che la sua apparente indifferenza sui fatti di tutti i giorni non lo era affatto, vero il contrario. Consapevole della fine di questo mondo osservava anche il minimo dettaglio essendo però in gran parte proiettato già oltre.
Io credo sarebbe dovere nostro, intendo non come “società civile” (cfr. Black Tulips) ma come società che vuole conoscere e interrogarsi, fare in modo di dare significato e continuità attraverso le espressioni artistiche più appropriate ai molteplici temi che lui ha indagato – il problema della lingua e del linguaggio, la periferia diffusa, l’integrazione dei popoli, la mutazione antropologica, la solitudine, l’alienazione, l’arte, lo sfruttamento delle persone, la prostituzione … – e che sono soprattutto di vitale importanza dal punto di vista della trasformazione sociale e antropologica che stiamo vivendo.
Ma forse, vista la ricchezza e la complessità, meglio non correre questo azzardo, ci si potrebbe trovare di fronte ad iniziative superficiali tese alla sola ricerca del consenso effimero.
E quasi certamente, Vitaliano non gradirebbe.
_____
1) Vitaliano Trevisan, Intervista di Francesca Visentin pubblicata sul Corriere del Veneto il 16 ottobre 2021
2) Vitaliano Trevisan, Black Tulips, Einaudi, Torino, 2022
3) Benjamìn Labatut, La pietra della follia, Adelphi, Milano, 2024
4) Walter Benjamin, Il narratore, Einaudi, Torino, 2004
5) Giuseppe Barbieri, in arte Palladio, Terra Ferma, Vicenza, 2008
6) Emanuele Trevi, Postfazione, da La Trilogia di Thomas, Einaudi, Torino, 2024

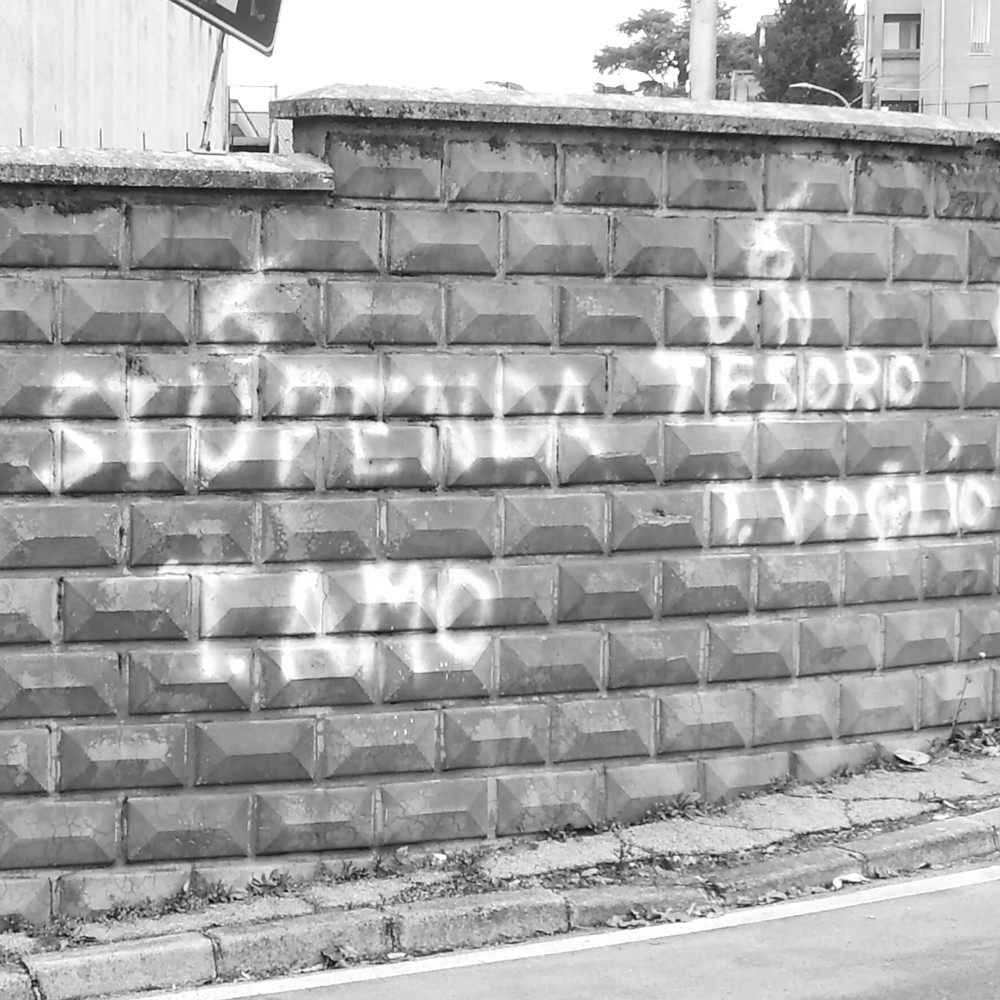

grazie per questo ricordo a Trevisan, scrittore “scomodo” anche ai benpensanti proprio per la sua schiettezza, la sua onesta scrittura, la sua lungimiranza
Già Vanna. Uno scrittore unico. Grazie.
V
Non conosco Trevisan. E’ un opportunità che mi è stata offerta, grazie.
Se lo legga fino in fondo Rita, non rimarrà delusa.
E’ come andare in montagna. Dipende cosa vuoi vedere, ma se cerchi l’essenza in Trevisan la trovi, e ti potrebbe spaventare, perché la sua lettura è crudele, non lascia spazio, è in bianco e nero, ma non perchè si sia fronte a un manicheo, ma perchè tra il bianco e il nero c’è una infinita sfumatura di grigi e Vitaliano dava voce a tutti.
Come i fiori in montagna, se non li osservi, ti sfuggono.
Grazie a lei.
V.
Apprezzo questo allargamento di Altitudini a grandi scrittori che non scrivono di montagna o alpinismo. Grazie per il pezzo su Trevisan, scrittore onesto e sincero sulla fatica, e per alcuni la tragedia, di vivere in una società come la nostra.
Grazie Alberto. Serve ringraziare la redazione che apre anche ad altri mondi. E’ interessante il Suo passaggio sulla fatica perchè individua esattamente il percorso. Vitaliano ha faticato tantissimo senza risparmiarsi mai, ma del resto la fatica accumuna qualsiasi sfida, dallo scrivere, all’alpinismo. Sarebbe bello dare voce a tutte le fatiche del mondo, e Vitaliano ci ha provato. Poi sul vivere in una società come la nostra, sappiamo la fatica che serve.
V.